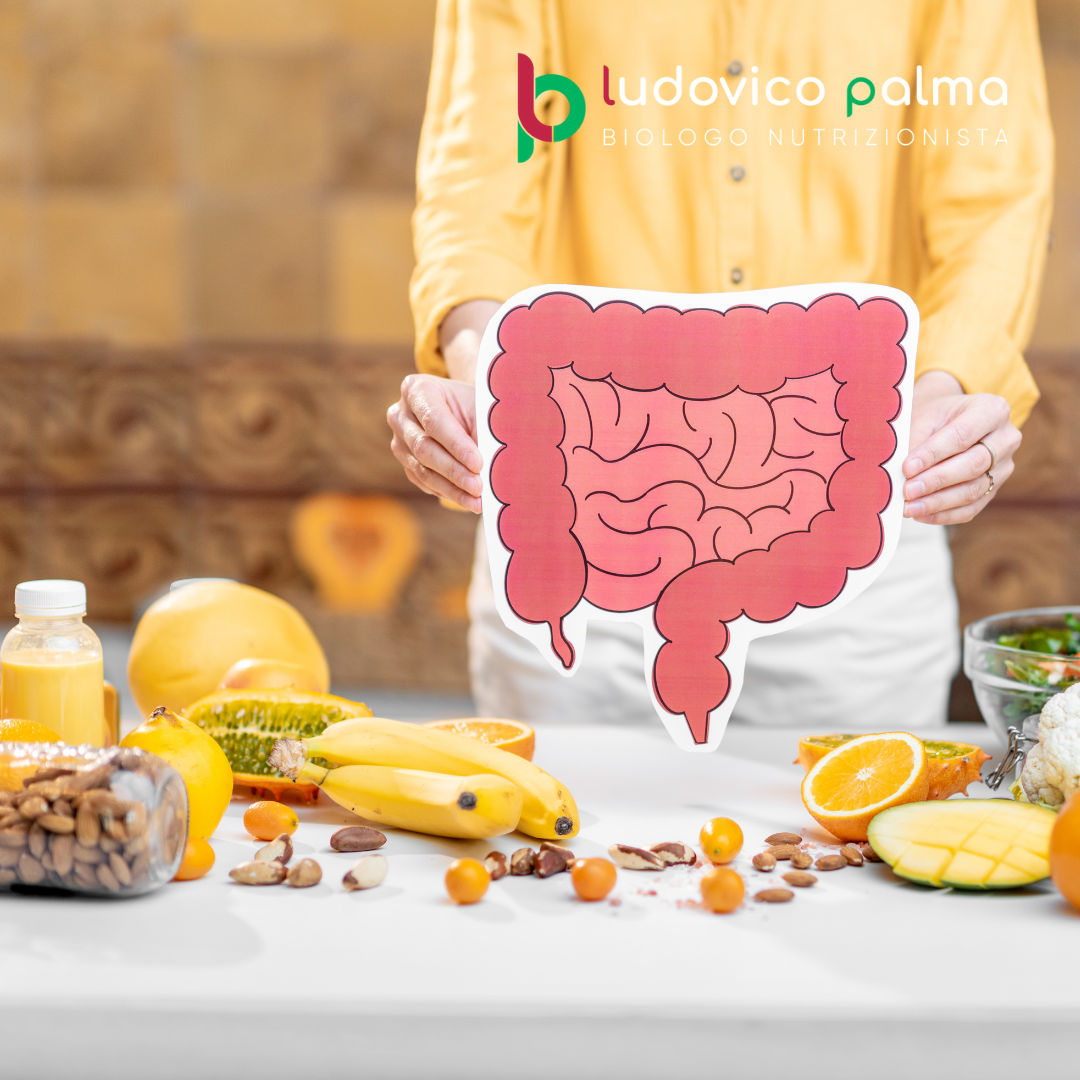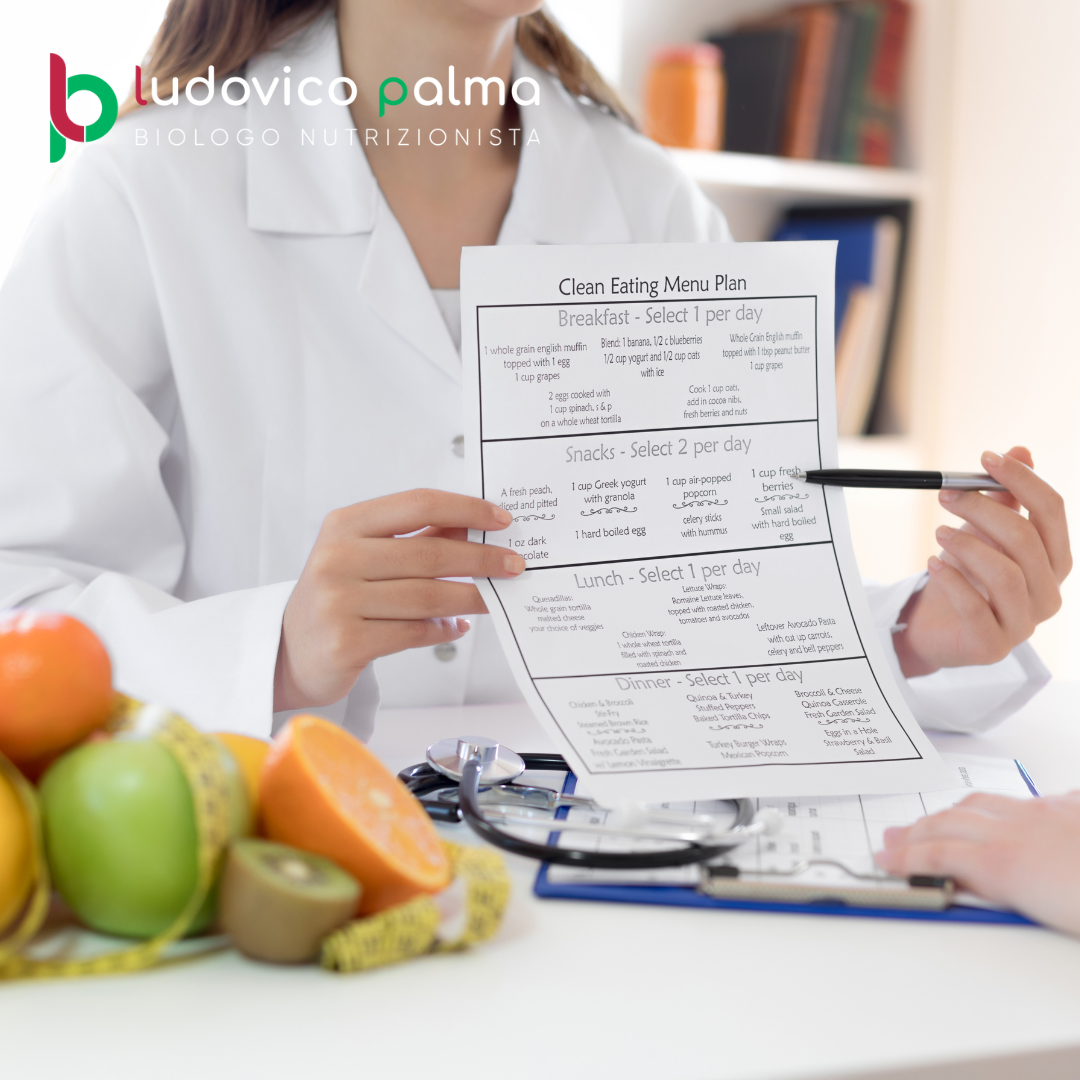Con l’arrivo dell’autunno, le castagne tornano protagoniste della nostra alimentazione. Questo frutto antico, spesso sottovalutato, è invece fonte di energia, fibre e micronutrienti ed inoltre molto versatile in cucina.
In questo articolo vediamo insieme le proprietà nutrizionali, i benefici per la salute e come inserirle correttamente in un’alimentazione equilibrata.
Castagne: cosa sono?
Le castagne sono il frutto dell’albero di castagno (Castanea sativa), diffuso in molte regioni italiane e appartenente alla famiglia delle Fagacee, lontano parente di quercia e faggio.
Questi frutti sono delle noci particolari in cui il materiale di riserva è costituito da carboidrati e non da grassi. Così, a differenza della frutta secca come noci o mandorle, le castagne hanno un profilo nutrizionale molto più simile ai cereali: sono infatti ricche di carboidrati complessi e naturalmente prive di glutine. In particolare, le castagne hanno un ottimo contenuto di amido, anche superiore alle patate, oltre che zuccheri semplici come glucosio, fruttosio, raffinosio e lo stachiosio. Questi ultimi due possono fermentare nel colon e la cui presenza può spiegare i fenomeni di flatulenza che alcuni associano al consumo di castagne. Per questo motivo chi segue una dieta LOW FODMAP dovrà evitare questo frutto oppure consumarlo di rado ed in piccole quantità.
Valori nutrizionali (per 100 g di prodotto fresco)
- Calorie: circa 165 kcal
- Carboidrati: 36 g
- Zuccheri: 8 g
- Fibre: 5 g
- Proteine: 2–3 g
- Grassi: 1,5 g (quasi tutti insaturi)
- Vitamine: Vitamina C, B1, B2, B6, acido folico
- Minerali: Manganese, rame , potassio, magnesio, ferro
La cottura delle castagne aumenta leggermente l’apporto energetico che per le castagne può arrivare a circa 250 kcal.
Benefici per la salute
1. Energia naturale e sazietà
Grazie al loro contenuto di carboidrati complessi, amido su tutti, le castagne forniscono energia a lungo termine. Sono ideali come spuntino autunnale o in sostituzione del pane nei pasti principali.
2. Fonte di fibre per l’intestino
Le fibre contenute aiutano a regolarizzare il transito intestinale, migliorano la digestione e contribuiscono al senso di sazietà.
3. Alleate del sistema nervoso
Le vitamine del gruppo B (soprattutto B6) supportano il corretto funzionamento del sistema nervoso e possono aiutare a contrastare stanchezza e stress.
4. Amiche del cuore
Grazie al contenuto di grassi “buoni” e di potassio, favoriscono la salute cardiovascolare.
Si possono mangiare se si è a dieta?
Assolutamente sì, ma con moderazione. Le castagne sono più caloriche rispetto ad altri frutti, ma se consumate nelle giuste quantità (circa 4–5 per uno spuntino), possono far parte tranquillamente di un piano alimentare equilibrato, anche ipocalorico.
Chi segue una dieta senza glutine può consumare questo frutto in tutta sicurezza. Tuttavia, le persone con diabete o insulino-resistenza dovrebbero prestare attenzione alle porzioni, in quanto le castagne hanno un impatto medio sull’indice glicemico.
I soggetti allergici devono invece prestare più attenzione per la possibilità di cross-reazioni a causa di alcune proteine presenti nel frutto. In particolari persone allergiche al lattice e polline.
Come consumarle ?
Le castagne possono essere consumate:
- Arrostite (caldarroste)
- Bollite
- Sotto forma di farina di castagne, perfetta per dolci e pane
- In zuppe, minestre o piatti autunnali
- Secche, si possono utilizzare in diverse preparazioni ma sempre prima reidratate e cotte.
Se si vuole dimagrire il consiglio è di evitare l’abbinamento ad altri alimenti molto calorici, come formaggi o dolci, per non eccedere con le calorie.
Ecco alcuni esempi di ricette originali che potrebbero essere utilizzate anche a dieta:
- Insalata autunnale con castagne, zucca e feta
- Frittata proteica con castagne, albumi e spinaci
- Pollo in crema di castagne e yogurt greco
- Muffin proteici con farina di castagne e proteine in polvere
In sintesi
Le castagne non sono solo un piacere della stagione autunnale, ma anche un alimento nutriente e benefico. Se inserite nel modo corretto all’interno della dieta, possono diventare un’ottima fonte di energia, fibre e micronutrienti.